MENO TASSE SUGLI STIPENDI: MA PERCHE’ SIAMO POVERI?
L’INCHIESTA DEL CORRIERE DELLA SERA
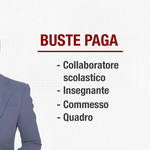 Un salario, anche il più basso, si può definire tale quando garantisce al lavoratore la copertura dei bisogni primari e lascia un minimo di margine per gli imprevisti e le piccole spese discrezionali. Cosa è successo ai redditi da lavoro dipendente negli ultimi anni?
Un salario, anche il più basso, si può definire tale quando garantisce al lavoratore la copertura dei bisogni primari e lascia un minimo di margine per gli imprevisti e le piccole spese discrezionali. Cosa è successo ai redditi da lavoro dipendente negli ultimi anni?
Per rispondere occorre distinguere due aspetti: i salari lordi e i salari netti. I salari lordi si dovrebbero adeguare con aumenti proporzionali al costo della vita attraverso il rinnovo dei contratti collettivi: ogni 3 anni nel settore pubblico, ogni 3-4 anni nel privato. I salari netti invece dipendono dalle politiche fiscali.
Gli aiuti fiscali
Il primo intervento è del 2022 targato Draghi. Nel 2023 il governo Meloni effettua un taglio aggiuntivo del cuneo fiscale, ossia dei contributi a carico dei dipendenti, che rispetto al 2019 passano dal 9,19% al 2,19% per i redditi fino a 25.000 euro e al 3,19% fino a 35.000 euro. Nel 2025 viene cancellato il taglio del cuneo fiscale e al suo posto introdotta una detrazione di 1.000 euro tra i 20.000 e i 32.000 euro, che poi decresce progressivamente fino a 40.000 euro. Per gli incapienti sono previsti dei bonus. Nel 2024 la premier Meloni accorpa anche i
primi due scaglioni Irpef e riduce l’aliquota dal 25% al 23% tra 15.000/28.000 euro. Con la nuova Legge di Bilancio il governo intende ridurre l’aliquota Irpef dal 35% al 33% per la fascia di reddito 28.000/50.000 euro. Una riduzione che non verrà applicata sui redditi che superano i 200.000 euro. E, allora, perché si continua a parlare di perdita di potere d’acquisto? Con l’aiuto degli economisti Marco Leonardi, Leonzio Rizzo e Riccardo Secomandi, utilizzando i dati dell’Aran che tratta per lo Stato e dei contratti collettivi, analizziamo quattro casi concreti: due nel pubblico e due nel privato, con redditi sotto i 28.000 e poco sopra i 40.000 euro.
I contratti pubblici
Prendiamo il contratto collettivo Istruzione e Ricerca, che riguarda circa 1,2 milioni di dipendenti pubblici, tra cui oltre 950.000 insegnanti. Il contratto in vigore è quello del triennio 2019-2021, firmato solo il 6 dicembre 2022, quasi quattro anni dopo l’inizio del periodo che avrebbe dovuto coprire. Gli aumenti previsti per il 2019 sono quindi arrivati in busta paga solo a fine 2022. Il 27 febbraio 2025 si è tenuto il primo incontro tra Aran e sindacati per il rinnovo del contratto 2022-2024, anch’esso già scaduto. Dal 2022 al 2025 vengono corrisposte soltanto le indennità di vacanza contrattuale, ossia aumenti minimi dati in attesa della firma del contratto. L’indennità parte da +0,3% dal 1° aprile 2022, sale a +0,5% dal 1° luglio 2022 e, da gennaio 2024, si arriva complessivamente a un aumento del 3,5%. Questa misura assorbe circa la metà delle risorse disponibili per gli aumenti del triennio 2022-2024, pur in assenza di un contratto firmato. Seguono altre piccole indennità che anticipano gli incrementi previsti per il triennio 2025-2027: a luglio 2025 è del +1%. Al momento del rinnovo contrattuale, queste indennità — che solo dopo tre anni arrivano al +4,5% — saranno assorbite negli aumenti definitivi e saranno riconosciuti
gli arretrati. Vediamo le buste paga.
Collaboratore scolastico
Per capire l’effetto reale sul reddito consideriamo tre fatti: crescita dello stipendio lordo attraverso la contrattazione, impatto dell’inflazione e interventi fiscali. Solo così possiamo misurare il guadagno o la perdita effettivi. Un bidello con oltre 35 anni di carriera parte nel 2019 da 1.918 euro lordi mensili, con il rinnovo 2019-2021 arriva a 2.013 euro e nel 2025 guadagna 2.094 euro. L’aumento lordo è del 9,17%. L’inflazione nello stesso periodo, però, è del 20,6% (Eurostat). Per mantenere invariato il potere d’acquisto del reddito netto avrebbe dovuto guadagnare 3.269 euro in più all’anno. Le misure fiscali riducono parzialmente il danno. Gli interventi del governo Meloni fanno risparmiare 1.194 euro, di cui 741 euro per il taglio del cuneo e 453 euro per le aliquote. La perdita definitiva, tenendo conto anche delle misure decise da Draghi, è di 1.756 euro l’anno. Nelle tabelle in pagina i dettagli.
Insegnante di scuola superiore
Un prof di scuola superiore con 28-34 anni di carriera parte nel 2019 da 2.885 euro lordi mensili, con il rinnovo 2019-2021 arriva a 3.029 euro e nel 2025 guadagna 3.144 euro. L’aumento lordo è dell’8,98%. La perdita di potere d’acquisto è di 3.754 euro annui. Sul fronte fiscale, il prof non beneficia del taglio del cuneo perché guadagna più di 40 mila euro lordi, ma risparmia per la riforma Meloni 442 euro, di cui 260 per la riduzione dell’aliquota al 23% e se l’Irpef scenderà al 33% fino a 50.000 euro altri 182 euro. Rispetto al 2019 questo insegnante perde in potere d’acquisto 2.307 euro l’anno.
I contratti del settore privato
Passiamo ora al contratto collettivo del Terziario, firmato da Confcommercio e applicato a oltre 3 milioni di lavoratori. Il contratto 2019 è rinnovato solo nel marzo 2024 e vale, coneffetto retroattivo, dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2027. Gli aumenti previsti sono: +2% da gennaio 2023, +1,9% da aprile 2023, +4,2% da aprile 2024, poi +1,8% da marzo 2025 e +2% da novembre 2025, fino a +240 euro lordi mensili nel 2027. Per compensare il ritardo vengono corrisposte due una tantum da 350 euro ciascuna per i livelli più bassi, somme erogate una sola volta e non integrate stabilmente nello stipendio.
Commesso
Un commesso di IV livello parte nel 2019 da 1.584 euro lordi mensili e raggiunge 1.802 euro nel novembre 2025, con un aumento del 13,77%. Con l’inflazione al 20,6% il suo potere d’acquisto, senza considerare le riforme fiscali, si riduce di 2.458 euro l’anno. Il contributo del governo Meloni al taglio delle tasse è di 760 euro per il cuneo e di 398 per le aliquote. Sommati agli sgravi di Draghi, il commesso perde 933 euro l’anno.
Responsabile vendite
Nel 2019 un responsabile vendite (quadro) guadagna 2.620 euro lordi mensili. A novembre 2025 raggiunge i 2.933 euro, con un aumento dell’11,94%. L’inflazione gli sottrae 3.129 euro l’anno di potere d’acquisto sul reddito netto. Il contributo del governo Meloni è di 260 euro per l’Irpef al 23% e 186 euro per il taglio al 33% fino a 50 mila euro. Rispetto al 2019 perde 1.683 euro l’anno.
Il problema da risolvere
In tutti i casi analizzati i salari reali si riducono. I datori di lavoro, pubblici e privati, non adeguano le retribuzioni al ritmo dell’inflazione, i rinnovi contrattuali arrivano con anni di ritardo e gli aumenti non riescono a compensare la crescita dei prezzi. Come ricorda il Consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro (Cnel) nel suo XXVI Rapporto «la contrattazione collettiva rappresenta l’elemento primario attraverso cui operare per assicurare condizioni salariali più adeguate, che possano altresì
consentire dinamiche di spesa interna in grado di contribuire in maniera positiva alla ripresa produttiva». In parole povere: il potere d’acquisto non si salvaguarda con la riduzione delle tasse ma con aumenti salariali. Infatti, gli interventi fiscali varati dal governo, pur attenuando la perdita, non bastano a colmare il divario. E con ogni probabilità non saranno sufficienti neppure le ulteriori misure previste dalla Legge di Bilancio 2026: la detassazione di straordinari, festivi e lavoro notturno fino a un massimo di 1.500 euro — valida solo per il 2026 e per redditi sotto i 40.000 euro —, il taglio della tassazione al 5% per gli aumenti del 2025 e 2026 fino a 28.000 euro di reddito e la riduzione dell’imposta sui premi di risultato dal 5% all’1%. E alla fine di tutto questo nel carrello della spesa si possono mettere meno cose rispetto al 2019.
Milena Gabanelli e Simona Ravizza
(da corriere.it)
Leave a Reply