Giugno 27th, 2025 Riccardo Fucile
VUOLE EMERGERE COME GARANTE DI STABILITA’, RESTARE FUORI DAL LOGORAMENTO BELLICO E OFFRIRE UN’ALTERNATIVA SOLIDA ALL’EGEMONIA OCCIDENTALE
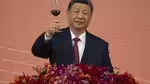 Mentre Israele bombarda le infrastrutture nucleari iraniane e gli Stati Uniti battezzano la loro “Operation Midnight Hammer”, la Cina alza la voce, ma senza alzare le mani. Nei comunicati ufficiali di Pechino, si leggono parole come “violazione della Carta delle Nazioni Unite”, “instabilità globale” e “rispetto per la sovranità”. Ma in filigrana si legge altro. La costruzione di una reputazione alternativa: quella di superpotenza che non ha bisogno di intervenire militarmente per modellare il mondo, l’unica interessata al rispetto del diritto internazionale mentre nessuno sembra più tollerarlo.
Mentre Israele bombarda le infrastrutture nucleari iraniane e gli Stati Uniti battezzano la loro “Operation Midnight Hammer”, la Cina alza la voce, ma senza alzare le mani. Nei comunicati ufficiali di Pechino, si leggono parole come “violazione della Carta delle Nazioni Unite”, “instabilità globale” e “rispetto per la sovranità”. Ma in filigrana si legge altro. La costruzione di una reputazione alternativa: quella di superpotenza che non ha bisogno di intervenire militarmente per modellare il mondo, l’unica interessata al rispetto del diritto internazionale mentre nessuno sembra più tollerarlo.
La Cina non sta con Teheran per ideologia, né contro Israele per convinzione. Sta con se stessa. Il conflitto, se limitato, è funzionale: allontana gli americani dall’Asia, fa crollare la fiducia nei mediatori occidentali, apre spazi diplomatici che Pechino può riempire con la sua narrativa multipolare e “responsabile”
Petrolio, BRI e Stretto di Hormuz: il vero campo di battaglia è energetico
La dipendenza cinese dal Medio Oriente non è un’opzione: è un assioma. Più del 40% del petrolio importato dalla Cina transita attraverso lo Stretto di Hormuz. Iran, Arabia Saudita, Emirati: sono tutti fornitori. Una crisi prolungata in quella zona colpisce Pechino direttamente al cuore – economico, energetico e infrastrutturale.
Nonostante l’Iran abbia minacciato a più riprese la chiusura dello Stretto dopo i raid americani e israeliani, la Cina non ha spinto né sostenuto questa scelta. Pechino, pur difendendo Teheran a parole, ha lasciato volutamente aperta quella valvola geopolitica, da cui transita circa il 20% del greggio mondiale. Il segnale è chiaro: la Cina non vuole destabilizzare il sistema di cui è diventata pilastro silenzioso. Sa che un’impennata del prezzo del petrolio manderebbe in recessione mezzo pianeta, a partire dai suoi partner commerciali. Invece di incendiare il mercato, lo tiene sul filo. È una dimostrazione di forza al contrario: potremmo stringere, ma non lo facciamo – per ora. E così dimostra di avere leve globali senza doverle usare.
Qui infatti entra in gioco la doppia logica cinese: da un lato, condanna gli attacchi occidentali per non perdere l’accesso alle fonti energetiche; dall’altro, sfrutta la destabilizzazione per ridurre la presenza americana nella regione, accrescere la propria e lanciare segnali. Una guerra lunga, ma non catastrofica, significherebbe anche maggior margine di manovra per la Belt and Road Initiative, oggi in stallo per instabilità e sanzioni. In gioco non c’è solo il greggio: c’è la legittimità a essere potenza sistemica.
Strategia a due volti: moralismo in pubblico, realismo in privato
Ufficialmente, la Cina è “preoccupata”. Sostiene l’ONU, invita al dialogo, offre addirittura bozzetti di mediazione multilaterale. Ma non è coinvolta in alcuna trattativa concreta. La sua vera influenza si esercita altrove: nella logistica, nella finanza, nella
tecnologia dual-use.
Con l’Iran, la Cina ha una relazione non ideologica, ma funzionale. Gli ha aperto le porte ai BRICS e alla SCO, ha firmato un accordo venticinquennale di cooperazione su energia, finanza, telecomunicazioni. Non difende Teheran: lo integra nella propria visione alternativa dell’ordine mondiale. Come con la Russia, anche con l’Iran la relazione è guidata non dalla fiducia, ma dalla convenienza – e dalla comune ostilità verso l’unilateralismo americano.
Il conto ucraino: quanto costa il fronte che logora l’Occidente
Secondo il Congressional Budget Office, dal febbraio 2022 a oggi, gli Stati Uniti hanno speso in Ucraina oltre 175 miliardi di dollari, tra aiuti militari, economici e umanitari. Di questi, più di 90 miliardi sono confluiti direttamente in forniture belliche: sistemi missilistici HIMARS, munizioni d’artiglieria, droni da ricognizione, blindati, sistemi antiaerei Patriot e Storm Shadow, oltre a ingenti risorse per l’addestramento delle truppe e il supporto logistico. Altri 60 miliardi sono stati destinati al sostegno al bilancio dello Stato ucraino, al funzionamento delle istituzioni e ai servizi di base, mentre una quota crescente va alla ricostituzione delle scorte del Pentagono, che si stanno esaurendo.
Ma oltre al costo diretto, c’è il prezzo strategico: Washington ha consumato una porzione critica delle sue riserve di missili antiaerei e munizioni a guida di precisione, che richiedono anni per essere rimpiazzate. Secondo la RAND Corporation, l’industria bellica americana produce a un ritmo troppo lento per sostenere contemporaneamente Ucraina, Israele e – ipoteticamente – Taiwan. Ogni dollaro speso oggi a est dell’Europa è un dollaro in meno per contenere la Cina nel Pacifico. E Pechino lo sa. Osserva. E aspetta.
Il paradosso degli alleati asiatici: la Nato ha i muscoli, ma non le
braccia
La mossa più interessante degli ultimi giorni non viene da Teheran, né da Washington. Viene da Tokyo e Seoul. I due principali alleati asiatici della Nato hanno disertato il summit in Olanda, smentendo la narrativa occidentale sulla compattezza della coalizione tra Indo-Pacifico e Occidente, e sul cordone a difesa del Mar Cinese.
Dietro le formule diplomatiche si cela un dato strategico: Giappone e Corea non vogliono essere trascinati in un’altra guerra americana, tanto meno se condotta contro un partner energetico rilevante e in un contesto percepito come troppo lontano dalla sicurezza regionale. In gioco c’è anche la tenuta di AUKUS e del sistema di alleanze regionali, già in difficoltà. La Cina lo sa, e testa i limiti della deterrenza americana, proprio dove dovrebbe essere più salda.
Taiwan sullo sfondo: Riprendersi il mondo senza sparare un colpo
Come nel 1997, quando Hong Kong tornò alla Cina senza un colpo di pistola, oggi Pechino punta a riconfigurare l’ordine globale non con le guerre, ma con le attese, le connessioni economiche, la pressione strategica silenziosa. Non conquista: si fa lasciare spazio. E quando arriva, il vuoto è già stato creato dagli altri.
Secondo questa logica, la Cina non ha bisogno di attaccare Taiwan. Le basta osservare e preparare. Mentre l’America spreca risorse in Medio Oriente e nell’Europa orientale, Pechino accumula tempo, mezzi e narrativa. Non è un caso che nel linguaggio dei media statali sia tornato il concetto di “riunificazione inevitabile”. La strategia non è bellica, è logorante: intimidazione a bassa intensità, isolamento diplomatico, dominio informativo.
Se Washington non può garantire la sicurezza energetica dei suoi partner, né quella territoriale dei suoi alleati europei, come potrà garantire la sopravvivenza di Taiwan in caso di crisi vera? La domanda si insinua nell’opinione pubblica e tra gli alleati. E Pechino si assicura che resti lì, come un dubbio strategico, alimentato giorno dopo giorno dalla distrazione americana.
Afghanistan: 20 anni di scacchi sotto gli occhi del weiqi cinese
In Afghanistan, gli Stati Uniti hanno speso oltre 2.000 miliardi di dollari – circa 300 milioni al giorno per vent’anni – per condurre una guerra che, alla fine, ha restituito il potere agli stessi talebani da cui era partita nel 2001. Un conflitto pensato con la logica degli scacchi: attacco frontale, rovesciamento del re, occupazione del centro. Ma il terreno era quello del weiqi, il gioco cinese dell’accerchiamento, della pazienza strategica, dell’erosione laterale.
Mentre la NATO bombardava, la Cina osservava e costruiva. Non ha mai sparato un colpo, ma ha circondato il campo con infrastrutture, investimenti e accordi a lungo termine. Già dal 2012, Pechino si inseriva nei vuoti lasciati dall’ISAF: miniere di rame, giacimenti d’oro, terre rare strategiche, zone industriali al confine con lo Xinjiang. Ha sfruttato la stabilità ottenuta a caro prezzo dagli occidentali per pianificare la propria penetrazione morbida, senza provocare, senza esporsi, ma tracciando linee invisibili come nel weiqi.
Non guerra fredda, ma pace calda: il commercio come trincea
Da circa 20 anni, Wang Jisi della Peking University, dice che “piuttosto che parlare di guerra fredda tra Cina e Occidente, bisognerebbe parlare di pace calda”. La Cina non fa la guerra fredda, fa la pace calda del commercio, dei contratti, delle materie prime. È tra i primi partner economici degli Stati Uniti, dell’Unione Europea e perfino del Giappone e della Corea del Sud – paesi con cui ha tensioni crescenti su Taiwan, sul Mar Cinese Meridionale, sui diritti umani. Ma il paradosso è questo:
sono loro a dipendere da Pechino, non il contrario. Sulle terre rare, ad esempio – materiali essenziali per le batterie, l’elettronica avanzata e le tecnologie militari – la Cina controlla oltre il 90% della lavorazione globale.
Ha costruito un sistema a prova di sanzione, una rete che collega Iran, Russia, Africa, Asia Centrale e Sud America, da cui può rifornirsi o a cui può vendere se l’Occidente chiude una porta. Quando Canberra ha bloccato l’export di carbone, la Cina ha virato sul carbone indonesiano. Quando Washington ha imposto dazi sui chip, Pechino ha investito miliardi nell’autonomia tecnologica e nei semiconduttori “di Stato”. È una strategia a ventaglio, non a muro: se una sponda cede, ce n’è sempre un’altra a cui appoggiarsi.
Il grande gioco cinese: caos controllato, silenzio utile
La Cina non cerca di vincere le guerre. Cerca di vincere nel mondo che le guerre lasciano dietro di sé. È l’unica potenza globale a non essere impantanata in alcun conflitto armato da decenni. Non certo perché sia neutrale, ma perché cerca di instaurarsi agli occhi del mondo come l’unica grande potenza responsabile. Questo accresce il suo soft power.
L’obiettivo non è salvare l’Iran, ma dimostrare che può sopravvivere alle guerre senza logorarsi, cercando di far passare un unico messaggio, ovvero che chi si schiera con lei avrà almeno una certezza: quella di non dover combattere. Quale sia il prezzo da pagare in termini di libertà, questo è un altro discorso. Ma è un discorso che riguarda ogni forma di imperialismo – che sia americano, russo o cinese – quando pretende di esportare la democrazia o ribaltare un regime. E mentre le democrazie liberali si spaccano, si indeboliscono, si inseguono in una sterile battaglia tra moralismo e interessi, la Cina capitalizza ogni crisi per rafforzare la propria narrativa: ordine, stabilità, continuità. A qualunque costo.
Se l’Europa resta divisa, disillusa e assente, non potrà più scegliere di stare dalla propria parte, né dalla parte della civiltà democratica che dice di voler difendere. Perderà l’iniziativa, il linguaggio e, infine, la possibilità di pesare. Perché nel mondo multipolare che si sta formando, la neutralità è già una forma di resa.
(da agenzie)
argomento: Politica | Commenta »
Giugno 27th, 2025 Riccardo Fucile
CI SERVONO 300 CARRI ARMATI E 1000 MEZZI CORAZZATI, MANCANO DRONI PER ATTACCARE E SISTEMI ADEGUATI PER CONTRASTARLI (CANNONI A RAGGIO LASER, CONTROMISURE ELETTRONICHE E CYBER) … IL SISTEMA ANTI-AEREO E ANTI-MISSILISTICO E’ DEBOLE, L’UCRAINA RIESCE AD ABBATTERE IL 90% DEI MISSILI RUSSI IN ARRIVO SUL SUO TERRITORIO. ISRAELE HA PERCENTUALI MIGLIORI. L’ITALIA, IN QUESTO SENSO, HA DIFESE RIDICOLE
Ogni ragionamento sulle prossime spese militari in ambito Nato non può che partire dall’analisi dell’esistente, lo studio delle guerre in corso, e il calcolo delle necessità future. […] Che cosa ci manca? Innanzitutto le truppe. Si pensi solo che ai tempi della Guerra Fredda, la sola Italia doveva garantire una massa di 22 brigate operative dell’esercito, pari a 220 mila soldati armati e schierati, in gran parte nel Nord-Est.
dall’analisi dell’esistente, lo studio delle guerre in corso, e il calcolo delle necessità future. […] Che cosa ci manca? Innanzitutto le truppe. Si pensi solo che ai tempi della Guerra Fredda, la sola Italia doveva garantire una massa di 22 brigate operative dell’esercito, pari a 220 mila soldati armati e schierati, in gran parte nel Nord-Est.
Oggi i numeri sono drasticamente calati. L’Italia, oltre 30 mila unità in Marina e circa 40 mila in Aeronautica, ha 90 mila soldati di terra, di cui 60 mila operativi. Simili sono i numeri francese, tedesco o britannico. Intanto la Russia si prefigge di schierare in tempi brevi un esercito di 1 milione 600 mila effettivi. Ecco perché uno dei capitoli sarà il rafforzamento degli organici: per l’Italia è allo studio l’arruolamento di 40 mila soldati e soldatesse in più, ma anche una riserva di almeno 10 mila ex militari, freschi di addestramento e veloci da rimettere eventualmente in linea.
Per equipaggiarli a dovere, c’è una commessa affidata a un consorzio italo-tedesco tra Leonardo e Rheinmetall: 300 carri armati più 1000 mezzi corazzati per il trasporto truppa, da costruire in una fabbrica a La Spezia, costo stimato circa 10 miliardi spalmati in diversi anni. Il secondo clamoroso deficit riguarda la difesa dal cielo
Dice il generale Giorgio Battisti, presidente della commissione militare del Comitato Atlantico Italiano, un think-tank collegato alla Nato: «La guerra in Ucraina insegna che occorre difendere i soldati da una vera e propria caccia all’uomo fatta con sciami di droni a basso costo». Fino a qualche tempo fa, la guerra dei droni era particolarmente sofisticata e gli apparecchi senza pilota molto costosi. Ora non è più così. I droni turchi, iraniani, russi, ucraini sono basici, poco costosi, prodotti a ritmo industriale, e però terribilmente letali.
Ecco perché l’Italia sta correndo ai ripari con una coproduzione italo-turca per produrre droni in casa. Dai droni però ci si deve anche difendere. E non avrebbe senso sparare un missile che costa 1 milione di euro, progettato per tirare giù un aereo nemico, contro un drone che vale pochi spiccioli. Tanto più che di questi droni ne possono arrivare più di mille al giorno e quei missili sono prodotti con il contagocce.
Una soluzione verrà da cannoni a raggio laser, in avanzata fase di sperimentazione in diversi Paesi. Per difendersi, si sperimentano contromisure elettroniche e cyber, utili a confondere il drone nemico. Altra falla delle forze europee è la difesa anti-aerea e anti-missilistica. L’Ucraina riesce ad abbattere il 90% dei missili russi in arrivo sul suo territorio. Israele ha percentuali migliori. L’Italia, la Francia, la Germania, in questo senso hanno difese francamente ridicole.
Ci sono due progetti comuni della Nato che faticosamente dovrebbero invertire la situazione. Il primo si chiama “Sky Shield”, avviato dalla Germania nel 2022, e ad oggi vi partecipano 25 Paesi europei: hanno scelto la tecnologia americana dei missili Patriot ed è già operativa una fabbrica in Germania che li produce su licenza. Italia e Francia hanno invece tenuto duro sulla tecnologia italo-francese del Samp/T, ma mancando grosse commesse questo programma cammina arilento.
(da “la Stampa”)
argomento: Politica | Commenta »
Giugno 27th, 2025 Riccardo Fucile
POI, TRA IL X E IL XIII SECOLO, PER VIA DI UN ENORME BALZO DEMOGRAFICO E DI UN INCREMENTO DELLA PRODUZIONE AGRICOLA E MINERARIA, LE ROTTE TERRESTRI NON BASTARONO PIÙ. E COSÌ I CINESI INIZIARONO AD ALLARGARSI
 Forse davvero fu una specie di globalizzazione. Attorno al X secolo, i cinesi avevano con i paesi stranieri i legami commerciali più fitti di qualunque altro popolo del pianeta.
Forse davvero fu una specie di globalizzazione. Attorno al X secolo, i cinesi avevano con i paesi stranieri i legami commerciali più fitti di qualunque altro popolo del pianeta.
La Cina esportava ceramiche di lusso e altre manifatture in mezzo mondo, a beneficio dei suoi acquirenti nel Medio Oriente, in Africa, in India e nel Sud-Est asiatico. E in tutte queste zone c’erano a loro volta fornitori che assicuravano le merci ai consumatori cinesi.
I contatti internazionali della Cina erano così estesi da influire sulla popolazione a tutti i livelli sociali, non soltanto sugli abitanti delle città portuali ma anche su quanti vivevano nell’entroterra, molto distanti dal mare.
Ed era in fondo la prima volta che la storia marittima della Cina prendeva quella scala smisurata. Per secoli, anzi per millenni, il suo rapporto con il mare era stato una cosa più modesta. Tutto era probabilmente cominciato dai fiumi. Imbarcazioni fatte per risalire le grandi arterie d’acqua che innervavano quella immensa regione del mondo.
Ma dai fiumi al mare la via fu breve. Sappiamo che già tra il 6000 e il 2000 a.C., a Guangzhou, quella che conosciamo oggi in Occidente come Canton, le canoe scavate erano usate anche per avventurarsi in mare aperto. Ma è difficile dire molto più di così.
Quello che sembra dai ritrovamenti archeologici è che per secoli e secoli la popolazione costiera avrebbe continuato a usare solo semplici mezzi capaci di galleggiare lungo le acque più vicine a riva.
Anche i testi scritti non dicono molto di più: forse la prima nave degna di menzione è quella citata nel Zhushu jinian, gli Annali su bambù, quando parla di un grosso pesce catturato nelle acque costiere e sacrificato a Huangdi…
Si era attorno al IV secolo a.C., all’epoca detta degli Stati combattenti, e a quanto pare non si trattava propriamente di popoli del mare… Anzi, forse fu solo allora che iniziarono a usare le vele, quelle che in cinese si chiamano fan.
E fu sempre nello stesso periodo che iniziarono a usare navi da guerra e a combattere sul mare. Sappiamo di una battaglia, avvenuta verso il 485 a.C., quando Fuchai, re di Wu, inviò una flotta dal Sud e sconfisse la marina del regno di Qi, nel Nord. E sappiamo pure che pochi anni dopo il regno di Yue nel Sud attaccò Wu dal mare sconfiggendolo.
Tutte avventure di cabotaggio, scontri avvenuti vicino a riva, ma il segno che i vari regni cinesi cominciavano a dare una diversa e nuova importanza al mare. Anche se ci vollero alcuni secoli perché cominciassero a osare un po’ di più. Nel 109 a.C. l’imperatore Han Wudi inviò una flotta con cinquemila soldati da Shandong verso la Corea. Poi fu la volta del Giappone.
Anzi per la verità il contatto sembra essere avvenuto a parti inverse: la prima testimonianza scritta in cui si menziona il paese di Wo, il Giappone appunto, risale all’anno 57 d.C. e parla di un ambasciatore proveniente da quelle isole che avrebbe reso omaggio alla corte cinese, riportandosene a casa un sigillo d’oro.
Ne venne fuori un lungo periodo di scambi diplomatici e commerciali: i giapponesi inviavano tessuti, legno di sapan, archi, frecce, schiavi e perle bianche; i cinesi, dal canto loro, mandavano seta, oggetti d’oro, perle, piombo, cinabro e soprattutto specchi di bronzo, tra gli oggetti più ricercati dell’epoca. Anche qui, come sulle strade di terra della via della seta, commercio voleva dire un crescente via vai di monaci buddhisti e un infittirsi degli scambi culturali.
Tali contatti tra Cina e Giappone furono mantenuti per lungo
tempo via Corea: era più facile navigare sfruttando la relativa vicinanza dell’isola, piuttosto che affrontare il mare aperto. L’influenza della civiltà cinese lascio segni di vasta portata nel mondo giapponese, a quel tempo ancora relativamente primitivo; e non solo sul piano culturale, ma anche politico e sociale.
Fu soprattutto a partire dalla dinastia Song, tra il X e il XIII secolo, che le cose cambiarono radicalmente. Un enorme balzo demografico, un grande incremento della produzione agricola e di quella mineraria; e infine il notevole aumento della produzione, con conseguente aumento del volume di scambi e delle reti di distribuzione.
Le rotte terrestri non bastarono più, insufficienti per gestire da sole la grande quantità di beni che ora venivano smerciati; era un problema di quantità e anche di peso e mole delle mercanzie.
Molti prodotti esportati dai Song, infatti, erano troppo pesanti per essere trasportati da cammelli e cavalli. Vasellami e piatti di porcellana, ad esempio, dovevano essere protetti e impacchettati in casse di legno per evitare che si rompessero.
E sebbene queste merci non fossero di per sé pesanti e ingombranti, lo diventavano una volta impacchettate per la spedizione.
Naturale, quindi, che simili trasformazioni incentivassero notevolmente la cantieristica navale:
Furono quelli i tempi in cui il commercio con le isole della Sonda e l’Oceano Indiano cominciò a crescere sempre di più.
Furono i tempi di quella sorta di globalizzazione che attraversò l’Asia più orientale. Anche per questo, crebbe a dismisura l’importanza dei porti cinesi meridionali. Oltre a Quanzhou, uno dei principali snodi commerciali divenne Guangzhou, a volte chiamata Canton, che si trova poco a nord di Hong Kong, sulla costa sud-orientale del paese
Da Guangzhou le navi partivano in direzione sud lungo la costa del Vietnam e poi attraverso lo stretto di Malacca. Da lì facevano rotta verso ovest, raggiungevano la costa occidentale dell’India e procedevano verso la penisola arabica.
In ciascun porto c’era un funzionario, il sovrintendente al commercio marittimo, incaricato di sorvegliare tutti i mercanti stranieri che arrivavano nel porto e di rilasciare licenze ai mercanti cinesi che facevano rotta verso paesi stranieri.
E normalmente, dove vi sono grandi possibilità di guadagno, finisce per affermarsi una volontà di controllo politico e militare. Fu soprattutto la dinastia Yuan, la dinastia mongola che prese il potere nel XIII secolo (quella per intenderci che ospitò anche Marco Polo), che cercò di scalzare i mercanti privati e creare una sorta di monopolio del commercio: un progetto che la vide impegnata anche in grandi missioni diplomatiche, con l’invio di tributi e mercanzie sino in India.
E fu ancora la dinastia Yuan a spingersi in una delle rare spedizioni marittime militari della storia cinese. Il Giappone era ricco e in quei secoli era diventato anche sempre più potente. Scriveva un monaco buddhista giapponese di quel periodo che i mongoli erano sbigottiti dalla qualità delle armature e dall’eccellenza degli arcieri del Giappone: «Le nostre corazze fan tremare persino gli dèi
Una volta sotto il loro controllo, i guerrieri del Giappone saranno in grado di conquistare la Cina e l’India […] nessun paese potrebbe resistere. Ecco perché i mongoli vogliono sottomettere il Giappone».
Non era solo questo: c’erano anche i buoni rapporti che il Giappone aveva con la precedente dinastia imperiale cinese – quella che gli Yuan avevano cacciato -, c’erano in gioco grandi quantità di tributi e tanto altro ancora.
Fu così che nell’ottobre del 1274 navi cinesi e coreane apparvero
al largo delle coste giapponesi, verso la baia di Hakata: la via più breve e più diretta venendo dall’estremità sud della Corea.
Un contingente marittimo di novecento navi e quindicimila soldati fu scagliato contro il Giappone. I cronachisti della dinastia annotarono che i mongoli avevano vinto, ma scrissero pure che la scarsa disciplina e la mancanza di frecce avevano obbligato le loro armate a ritirarsi… che era un modo per riconoscere, pur con dovuta prudenza, la vittoria folgorante del Giappone.
Le fonti giapponesi sostennero dal canto loro che fu un «vento divino», un kamikaze, a scacciare gli invasori, ma alcune recenti ricerche archeologiche suggeriscono che i cinesi furono sconfitti per colpa del mediocre equipaggiamento e del cattivo stato di manutenzione delle loro navi.
Kublai continuò a inviare ambasciatori in Giappone, ma invano. Sei anni dopo, però, l’esecuzione capitale da parte dello shogun di alcuni inviati dell’imperatore portò a un secondo tentativo d’invasione. Ma anche in questo caso il risultato fu un disastro per i mongoli e un altro kamikaze per i giapponesi.
Nel 1286, Kublai annunciò che avrebbe temporaneamente messo da parte i suoi piani di conquista del Giappone, e ciò a causa della problematica situazione in cui versava il confine meridionale con il Dai Viet: «Il Giappone non ci ha mai invasi, mentre proprio in questo momento l’Annam sta sconfinando al di qua delle nostre frontiere.
Meglio dunque mettere da parte il Giappone e concentrare tutte le nostre forze sull’Annam» decise saggiamente Kublai. Volendo evitare di subire una terza sconfitta sul mare, scelse di far avanzare i suoi eserciti sulla terraferma.
Dopo la morte di Kublai, nel 1294, un ufficiale propose al successore Temür di provarci di nuovo. La risposta del nuovo imperatore fu enigmatica: «Ora non è il momento. Ci penseremo».
Il che voleva dire in pratica: non se ne fa nulla e non aspettatevi da me un’altra parola sulla questione. Alla fine dei conti, il mare dimostrava di poter essere più un problema che la soluzione.
(da la Repubblica”)
argomento: Politica | Commenta »
Giugno 27th, 2025 Riccardo Fucile
“SIAMO STREMATI, GLI AIUTI UMANITARI NON BASTANO E L’ESERCITO SPARA AI PUNTI DI DISTRIBUZIONE”
Il conflitto tra Israele e Iran si è temporaneamente raffreddato, ma a Gaza il dramma della popolazione prosegue senza sosta. Per i gazawi, la guerra non è mai finita: a oltre 600 giorni dal 7 ottobre, i civili palestinesi vivono ancora sotto assedio, tra raid dell’Idf, carenze estreme di cibo, acqua, e altri beni di prima necessità, e una quotidianità segnata dalla paura e dall’incertezza. «Non è facile descrivere la situazione: è molto dura. Non c’è farina, né acqua pulita, tutto è carissimo. Le bombe ci circondano in ogni momento», dice a Open Nadera Mushtha, scrittrice palestinese cresciuta nel quartiere di Shujaiya a Gaza City. «Dal 2 marzo non è entrato più nulla nella Striscia. Qualche settimana fa sono arrivati alcuni aiuti – continua – Ma solo farina». «Stiamo davvero morendo di fame, siamo fisicamente stremati e i nostri corpi sono debilitati», ci spiega Sara Awad, scrittrice e studentessa che vive al nord di Gaza. «Non ricordo l’ultima volta in cui mi sono sentita sazia – prosegue -; mangiamo solo una volta al giorno, e ci vogliono ore per riuscire a procurarci il cibo».
della popolazione prosegue senza sosta. Per i gazawi, la guerra non è mai finita: a oltre 600 giorni dal 7 ottobre, i civili palestinesi vivono ancora sotto assedio, tra raid dell’Idf, carenze estreme di cibo, acqua, e altri beni di prima necessità, e una quotidianità segnata dalla paura e dall’incertezza. «Non è facile descrivere la situazione: è molto dura. Non c’è farina, né acqua pulita, tutto è carissimo. Le bombe ci circondano in ogni momento», dice a Open Nadera Mushtha, scrittrice palestinese cresciuta nel quartiere di Shujaiya a Gaza City. «Dal 2 marzo non è entrato più nulla nella Striscia. Qualche settimana fa sono arrivati alcuni aiuti – continua – Ma solo farina». «Stiamo davvero morendo di fame, siamo fisicamente stremati e i nostri corpi sono debilitati», ci spiega Sara Awad, scrittrice e studentessa che vive al nord di Gaza. «Non ricordo l’ultima volta in cui mi sono sentita sazia – prosegue -; mangiamo solo una volta al giorno, e ci vogliono ore per riuscire a procurarci il cibo».
Giovedì 26 giugno, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato la sospensione totale delle consegne di aiuti umanitari sulla Striscia, che di fatto non sono mai davvero ripresi. La decisione è arrivata a seguito delle pressioni del ministro di ultradestra Smotrich, che aveva minacciato di lasciare il governo se non fossero stati presi provvedimenti «per impedire che gli aiuti finissero nelle mani di Hamas». Poche ore prima dell’annuncio, l’ex premier Naftali Bennett aveva diffuso un video che mostrava uomini armati su un convoglio diretti al nord di Gaza, sostenendo che si trattasse dei miliziani di Hamas
intenti a sottrarre gli aiuti. Le Nazioni Unite hanno però attribuito i saccheggi a bande armate locali, e non al partito-milizia. Dallo scorso 19 maggio, quando Israele ha parzialmente revocato il blocco degli aiuti durato 78 giorni, a Gaza sono entrati soltanto 56 camion al giorno. Per l’Onu ne servirebbero diverse centinaia ogni giorno per rispondere ai bisogni urgenti della popolazione. «Gli aiuti umanitari sono fondamentali in tempo di guerra; tutti noi dipendiamo da essi per sopravvivere in questi tempi durissimi, ma il governo israeliano controlla e ci nega gli aiuti per aumentare la nostra sofferenza», afferma Sara.
La (non) distribuzione degli aiuti umanitari
La distribuzione degli aiuti umanitari nell’enclave palestinese è attualmente affidata alla Gaza Humanitarian Foundation (GHF), una controversa organizzazione non governativa registrata in Svizzera e negli Stati Uniti, a cui Israele ha appaltato – aggirando l’Onu e altre Ong – il sistema di assistenza umanitaria dal 26 maggio scorso. Il numero di punti di distribuzione allestiti, uno al centro e tre al sud della Striscia, è stato considerevolmente ridotto. Quelli rimasti, costruiti vicino a postazioni militari, si sono trasformati in trappole mortali: secondo l’Onu, a un mese esatto dall’inizio dell’attività, almeno 400 palestinesi affamati sono stati uccisi dall’esercito israeliano e 3 mila sono rimasti feriti. Più di dieci vittime al giorno, che si sommano a quelle del conflitto: 103 nelle ultime 24 ore, tre delle quali uccise mentre aspettavano in fila un pacco di alimenti. «Così il cibo per i civili viene trasformato in arma», ha denunciato pochi giorni fa l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha). James Elder, portavoce dell’Unicef, ha definito le scene ai centri di distribuzione come una versione reale degli «Hunger Games». In serata, il presidente della ong, Johnnie Moore ha fatto sapere di aver scritto una lettera al segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres per
chiedere di «lavorare insieme», poiché «è giunto il momento di affrontare il fallimento strutturale della fornitura di aiuti a Gaza e di correggere con decisione la rotta».
«L’Idf spara ai civili affamati che cercano di raggiungere i punti di distribuzione»
«L’esercito israeliano prende di mira chiunque riesca ad arrivare nei punti di distribuzione. E alcune persone prendono i sacchi di farina solo dopo moltissimi tentativi. Perché andiamo là? – si chiede Nadera – Perché abbiamo fame e dobbiamo nutrire le nostre famiglie». I prezzi per acquistare gli alimenti sono invece altissimi: «C’erano piccole quantità di riso e pasta già prima della chiusura dei valichi, ma sono carissimi e la gente non può permetterseli. I mercati ci sono, ma sono vuoti – prosegue – non c’è più nulla che possono vendere: niente carne, frutta o verdura. Nemmeno zucchero, latte o dolci», ci spiega. «Ci affidiamo al pane per nutrirci, ma un sacco di farina costa più di mille dollari». «Morte, fame, malattie, negazione e paura: questo è ciò in cui si sta trasformando il nostro amato Paese – le fa eco Sara – Una guerra senza fine, e Israele continua a ucciderci con le sue armi potenti». Intanto, l’organizzazione mondiale della Sanità ha fatto sapere di aver consegnato la prima spedizione di aiuti medici nella Striscia. «Nove camion carichi di forniture essenziali, 2 mila unità di sangue e 1.500 di plasma» hanno attraversato il territorio palestinese, ha scritto su X il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Le trattative per un cessate il fuoco
Nel frattempo, la trattativa per un cessate il fuoco, che include la liberazione degli ostaggi israeliani, potrebbe riprendere nei prossimi giorni. E un ruolo decisivo sarà giocato dall’interesse del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a impegnarsi concretamente nei negoziati. I mediatori egiziani e qatarioti provano, in ogni caso, a sfruttare l’effetto della fine della
conflitto tra Israele e Iran. Il portavoce del ministro degli Esteri qatariota, Majed Al Ansari, ha affermato alla Cnn che i negoziatori nel conflitto stanno sfruttando lo «slancio» della fine della guerra per riavviare i negoziati in stallo. Ansari ha affermato che Doha è stata in contatto con «tutte le parti» negli ultimi giorni per convincere Israele e Hamas a riprendere i colloqui. Intanto, dal vertice Nato de L’Aja e dal Consiglio europeo a Bruxelles è arrivato un pressing perché si ritorni al tavolo dei negoziati per il cessate il fuoco.
Ma i civili palestinesi sono stremati: dalla fame, dai bombardamenti, dalla distruzione e dalla carestia. «Tutti i miei sogni sono stati infranti in un istante, sia sul piano personale che negli studi, dato che la mia università ormai non è altro che cenere. Il dolore mi assale quando penso a me stessa o agli altri giovani che vivono tutto questo, mentre il mondo continua a guardare in silenzio», ci dice Sara. «Cerco di fare del mio meglio nonostante la guerra, ma tutto è difficile per noi – sottolinea Nadera -. Noi giovani abbiamo bisogno di credere che questa guerra finirà, anche per poter vivere come tutti i nostri coetanei nel mondo», afferma. «Sogniamo di vivere una giornata normale, senza l’odore della morte, mangiare senza avere lo stomaco affamato, e sentire la felicità al posto della fame e della paura. Può sembrare una cosa normale per gli altri. Ma per me – conclude Sara -, è un sogno».
(da agenzie)
argomento: Politica | Commenta »
Giugno 27th, 2025 Riccardo Fucile
IL TITOLARE DEGLI ESTERI E’ UN PERSONAGGIO A META’ TRA TOM WAMBSANGS DI SUCCESSION E MICHAEL SCOTT DI THE OFFICE
 «CONGRATULATIONS WORLD, IT’S TIME FOR PEACE», urla Donald Trump dal social Truth, la sua dependance da single dopo il divorzio con Elon Musk.
«CONGRATULATIONS WORLD, IT’S TIME FOR PEACE», urla Donald Trump dal social Truth, la sua dependance da single dopo il divorzio con Elon Musk.
«We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don’t know what the fuck they’re doing, you know what I mean?», rilancia qualche ora più tardi, dopo che Iran e Israele hanno violato il cessate il fuoco.
«They don’t know what the fuck they’re doing», scandisce bene al microfono mentre le pale dell’elicottero disturbano il suono come nei migliori degli action movie: non è né Leslie Nielsen che interpreta il presidente degli Stati Uniti in una commedia demenziale, né Logan Roy in una delle tante scene di Succession in cui spara fuck a tutto spiano, ma la cronaca di questi ultimi giorni di giugno piuttosto complessi.
Eppure, appena una settimana prima, dall’altra parte dell’oceano un ministro degli Affari esteri e della cooperazione
internazionale con lo sguardo spaurito da coniglio che viene abbagliato dai fari di una macchina, così lo descrive un post su X con duecentomila visualizzazioni e molti like, si era fatto sentire forte e chiaro.
«Ho anche parlato con i ministri di Israele e dell’Iran che erano le otto… otto e mezzo di mattina, e ho detto loro: basta con l’escalation. Cioè, anche all’Iran ho detto “Non reagite più”, ho detto a Israele “Basta, fermiamo qua”», ha dichiarato inflessibile Tajani, Antonio Tajani. Dalla Ciociaria con amore.
Al posto giusto
Se Trump è un Logan Roy con meno charm e più potere, restando nella metafora HBO, Antonio Tajani è una sorta di creatura mitologica, a metà tra Tom Wambsangs e Michael Scott di The Office.
Per chi fosse rimasto indietro con due delle serie migliori degli ultimi vent’anni, Tom Wambsangs è l’uomo che, nella lotta sanguinosa alla successione del gruppo Roystar, colosso dell’informazione statunitense, da esterno alla famiglia simbolo del quiet luxury riesce ad accaparrarsi la leadership, scavalcando figli e consanguinei del caso.
Dopo la morte di Berlusconi senior, avvenuta quasi in concomitanza con la fine della serie, giravano divertenti montaggi che sovrapponevano la sigla di Succession alla torre Mediaset di Cologno Monzese e al logo del Biscione: al posto di Kendal, Roman e Shiv Roy, Pier Silvio, Marina e Barbara Berlusconi, Milano 2 batte gli Hamptons, i produttori lungimiranti all’ascolto ci facciano un pensiero.
ANSA
In questo parallelismo all’italiana, Tajani si colloca come uomo giusto al momento giusto, il fedelissimo della prima ora salito a bordo dell’Azzurra, nave della libertà nel lontano 1994 e rimasto al fianco del capitano, o meglio, del Cavaliere, persino quando
questo era già passato a miglior vita, nei manifesti elettorali in cui se ne evocava lo spirito. «Una forza rassicurante», diceva lo slogan, mentre i due si stringono i pugni che tendono al cielo, un po’ Titanic un po’ Tommie Smith e John Carlos alle Olimpiadi del 1968.
E qui entra in gioco, pardon, scende in campo Michael Scott, il manager che punta a essere carismatico come Steve Jobs ma che risulta convincente come un fuffa guru di LinkedIn che usa parole come «mission» e «vision».
Perché se Forza Italia è il partito azienda per eccellenza, quello delle campagne elettorali fatte da Publitalia e dei gadget distribuiti porta a porta, del “meno male che Silvio c’è” e delle crociere promozionali, il suo leader non può che essere un cartellone pubblicitario ambulante, come del resto era noi-sappiamo-chi.
Berlusconi chi?
Tutto l’opposto, potremmo dire, dell’erede Tajani, che già in tenera età manifestava segni di malcelata sudditanza militando nell’Unione monarchica italiana e che tra tutte le qualità che gli si possono attribuire certo non sembra avere il dono della seduzione, del barzellettismo militante, dei sorrisi a centinaia di denti che abbagliavano gli interlocutori come quelli del suo amato predecessore.
Figlio di una professoressa di Frosinone e di un ufficiale dell’esercito, giornalista montanelliano, di lui Vittorio Feltri ha detto con la sua proverbiale pacatezza «un anonimo giornalista, un pistola qualsiasi». La sua formazione è al Torquato Tasso, uno di quei licei romani da cui, come vuole la vulgata, si forma la classe dirigente.
Tra gli illustri che hanno scarabocchiato i banchi prestigiosi di Via Sicilia: Giulio Andreotti, Vittorio Gassman, Carlo Verdone, Nanni Moretti, Paolo Mieli, Maurizio Gasparri, Luciana
Castellina. E poi lui, Tajani, lui che si è fatto battere da Walter Veltroni, con cui condivide la fede bianconera, al ballottaggio delle comunali nell’ormai lontano 2001, quando Roma viveva i suoi fasti e i sindaci non avevano ancora i social per scrivere i loro Ab urbe condita reel.
Nelle gallerie fotografiche di Umberto Pizzi, prezioso archivio analogico tra il nostalgico e il cafonal, Tajani abbraccia Francesco Cossiga, gira con la famiglia e un bel dalmata al seguito, bazzica sobriamente dalle parti del Gilda, istituzione della Roma by night, sfreccia su una Ferrari ma senza sbruffonaggine.
Lo sguardo è sempre un po’ preoccupato, la riga di lato, gli abiti sobri da pariolino gentiluomo, insomma niente a che vedere con quella milanesità rampante berlusconiana dentro cui si muove da oltre trent’anni e di cui adesso gestisce la pesante eredità politica che i figli del Cav., al contrario dei personaggi di Succession, hanno tenuto alla larga, salvo qualche sparuta dichiarazione.
Non proprio un leone
Perché Tajani, possiamo dirlo, non era nato con un cuor di leone, per citare la famosa litote manzoniana. La carriera politica del Don Abbondio dei Parioli, oltre al lungo corso europeo, è costellata di uscite infelici – e chi non ne ha, chiaro – ma anche da un mordente non proprio travolgente, per usare un’altra litote, applicato a contesti di estrema delicatezza come quello dei giorni recenti a cui fa fronte con una foto a dir poco scoraggiante.
Lo studio semivuoto dell’Unità di crisi della Farnesina, i computer spenti, uno screensaver di vent’anni fa, una pianta al centro del tavolo che sembra la cosa più viva di quella stanza. Quando tenta un’alzata di cresta da Bianca Berlinguer viene subito bacchettato, «capisco che non siete molto abituati a sentirvi fare delle domande», lui controbatte timido «non è che
posso avere la lezioncina», crisi rientrata.
Quando organizza eventi da lui ritenuti fondamentali per il ministero, come quello sul microbiota intestinale con tanto di prete e conduttrice di Elisir, genera non poche perplessità tra i funzionari della Farnesina. Per non parlare di quelle sue vecchie battaglie, «Tutti coloro che fanno uso di droghe pesanti hanno iniziato facendosi una canna» scriveva candidamente su Twitter nel 2019, omaggiando senza volerlo gli Offlaga Disco Pax, «gli amici del campetto passati dalle Marlboro direttamente all’eroina, alla faccia delle droghe leggere».
E poi ancora, il salario minimo che è roba da Unione sovietica, l’inaccettabile reddito di cittadinanza che va a «rom e stranieri», quel lungo sbrodolare di Benito Mussolini che ha fatto anche cose buone in diretta ai microfoni della Zanzara, palude non ancora bonificata, a differenza dell’Agro Pontino.
Botte di ferro
Non è poi così strano che oggi, alla luce della gravità del momento in cui ci troviamo, la sua posizione di figura centrale per gli equilibri internazionali, in un panorama in cui l’Europa sembra contare molto poco, l’Italia quasi niente, la sua presa tajaniana, risulti poco convincente.
«O porta sfortuna, oppure rinunci a fare queste dichiarazioni», gli ha detto Matteo Renzi in una delle sue performance da blastatore professionista del parlamento, riferendosi alle tante uscite del ministro che aveva scongiurato con convinzione un attacco israeliano all’Iran, poi anche uno spostamento dell’ambasciata da Teheran, sempre smentito o dalla storia in the making, come si dice in questi casi, o dal capo stesso del governo, nonché della sua coalizione. Nelle stesse ore, a decorazione del tutto, Matteo Salvini postava un video in cui raccoglieva giulivo fragole e peperoni del suo orto.
Chissà che effetto farebbe, una volta tanto, sentirsi in una botte
di ferro, invece che «un vaso di terracotta costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi di ferro», citando sempre Manzoni, sempre a proposito di Don Abbondio, o senza nemmeno saperlo, di qualche ministro.
(da editorialedomani.it)
argomento: Politica | Commenta »
Giugno 27th, 2025 Riccardo Fucile
“MOSCA STA INVESTENDO INGENTI SOMME DI DENARO IN AZIONI PROVOCATORIE IN VARI PAESI EUROPEI E STA ACCUMULANDO LA COSIDDETTA “FORZA DI INVASIONE PRIMARIA” (I MEZZI MILITARI NECESSARI PER UN’INVASIONE) LUNGO IL CONFINE CON LA FINLANDIA E L’ESTONIA
«I piani di Putin contro l’Europa sono già in atto. Capisco non sia una cosa piacevole  da sentire ma è realtà». Mykhailo Podolyak, primo consigliere del presidente ucraino, parla dopo l’ultimo vertice Nato cui ha preso parte anche Volodymyr Zelensky.
da sentire ma è realtà». Mykhailo Podolyak, primo consigliere del presidente ucraino, parla dopo l’ultimo vertice Nato cui ha preso parte anche Volodymyr Zelensky.
«Lo stiamo ripetendo da giorni. La Russia sta ora apertamente utilizzando tattiche potenziate di distruzione di massa, aumentando il numero di attacchi missilistici e droni contro aree residenziali e infrastrutture civili (scuole, ospedali, asili) in Ucraina. Anche il numero di droni a lungo raggio utilizzati in un’unica ondata di attacchi è aumentato.
La strategia dei raid contro le grandi città è cambiata: prima i russi lanciano droni su un’area residenziale, poi i missili da crociera e, quando sono in corso le operazioni di soccorso per tirare fuori i sopravvissuti dalle macerie, usano i missili balistici o ipersonici per ottenere il massimo numero di vittime civili. ».
Dell’adesione di Kiev alla Nato all’Aia non si è parlato e addirittura nel comunicato finale si è evitato di insistere sul concetto di aggressione russa. Tutto previsto. Pensate che la rinuncia all’adesione ucraina sia abbastanza per far sedere Putin al tavolo?
«Senza guerra, la Russia si troverebbe ad affrontare un forte aumento di problemi interni che non può risolvere. Sia la società che l’economia sono state orientate a questo scopo senza un’alternativa. Pertanto, ovviamente, non è l’espansione o la mancata espansione della Nato la ragione per cui Putin continuerà l’escalation e l’aggressione.
Ecco perché, per fermare davvero l’espansione vanno utilizzati
strumenti economici come le sanzioni, soprattutto nel settore energetico, oltre a e quelli militari che si traducono in un forte aumento delle capacità militari dell’Ucraina che sia fuori o dentro la Nato».
Zelensky ha detto di avere informazioni precise sui piani di attacco di Putin all’Europa. Cosa può dire in merito?
«La guerra in Ucraina, purtroppo, è solo l’inizio di una realtà molto più brutale in cui il dittatore russo vuole far precipitare l’Europa. I piani di aggressione contro gli Stati dell’Ue, […] sono un obiettivo fondamentale della Federazione russa.
Mosca sta investendo ingenti somme di denaro in azioni provocatorie in vari Paesi europei e allocando molte risorse in operazioni di sabotaggi e provocazione. Ma soprattutto sta accumulando la cosiddetta “forza di invasione primaria” (i mezzi militari necessari per un’invasione, ndr ) lungo il confine con la Finlandia e l’Estonia. E se l’area del Mar Baltico è un obiettivo prioritario, è ovvio che la Russia non può e non vuole considerare l’Europa un partner».
(da “Corriere della Sera”)
argomento: Politica | Commenta »
Giugno 27th, 2025 Riccardo Fucile
IL 12 GIUGNO IL GOVERNO IRANIANO HA COMUNICATO ALL’AIEA DI AVER PREDISPOSTO UN SITO NUOVO, COSTRUITO ANCHE PIÙ IN PROFONDITÀ RISPETTO AGLI 80-90 METRI DI FORDOW: UN IMPIANTO DI ALMENO 10 MILA METRI QUADRATI, CON CENTRIFUGHE E DEPOSITI DI STOCCAGGIO, CHE SI TROVEREBBE IN UNA DELLE MONTAGNE DELLA PROVINCIA DI ISFAHAN
 Il dubbio si fa certezza. Il tesoro radioattivo degli ayatollah, quei 408,6 chili di uranio arricchito al 60 per cento così prossimi alla soglia utile per costruire la bomba, sono nascosti in qualche laboratorio segreto della Repubblica islamica.
Il dubbio si fa certezza. Il tesoro radioattivo degli ayatollah, quei 408,6 chili di uranio arricchito al 60 per cento così prossimi alla soglia utile per costruire la bomba, sono nascosti in qualche laboratorio segreto della Repubblica islamica.
Uno di quelli mai segnalati all’Agenzia atomica dell’Onu (Aiea), o segnalati con omissioni e fuori tempo massimo, parte di una rete coperta di strutture che, dopo la guerra dei 12 giorni, compone un potenziale, e pericoloso, Piano b.
«La valutazione preliminare dell’intelligence fornita ai governi europei indica che le scorte di uranio in Iran rimangono per la maggior parte intatte», scrive il Financial Times, citando due fonti a conoscenza del dossier, finito, in queste ore, al centro di furiose polemiche tra la Casa Bianca, gli esperti di programmi nucleari, i servizi segreti e la stampa internazionale.
Il quotidiano inglese aggiunge che l’uranio non era più nel sito di Fordow . Anche il fatto che poi non sia stata rilevata alcuna variazione nel livelli di radioattività dell’aria fa ritenere che lo
stock sia stato trasferito altrove prima dell’attacco, come ha specificato l’Aise, i nostri servizi segreti esterni, durante l’audizione al Copasir di qualche giorno fa.
Si può discutere sul livello di distruzione che gli ordigni ad alta penetrazione hanno causato a Fordow — per Trump il sito è «annichilito», per il Pentagono «severamente danneggiato», per gli iraniani la valutazione va da «intonso» a «danni significativi» — ma il punto, ora, è un altro: dov’è nascosto il tesoro radioattivo di Khamenei? Di quanto è stato ritardato il programma nucleare? E, soprattutto: la Repubblica islamica ha delle centrifughe funzionanti in altri siti diversi da quelli, bombardati, di Fordow, Natanz e Isfahan?
«La risposta è sì, perché l’Iran ha una rete di strutture sotterranee per il programma nucleare non conosciute e da quel che risulta la capacità di arricchimento non è azzerata, perché ha ancora centrifughe funzionanti e componenti per produrne molte altre», spiega a Repubblica Jeffrey Lewis, professore al Middlebury Institute of International Studies di Monterrey ed esperto di politiche del nucleare.
Portare quasi mezza tonnellata di uranio al 60 per cento significa aver fatto gran parte del lavoro, perciò quella scorta è così preziosa. Arricchirlo fino al 90 (livello necessario per la bomba, ndr) è più semplice e rapido, con 250 centrifughe è una questione di 8-10 settimane».
Due giorni prima del raid americano, i satelliti hanno visto una fila di 16 camion fuori da una delle vie di ingresso di Fordow, il più protetto laboratorio iraniano per l’arricchimento. Che siano stati usati per spostare l’uranio non è detto. Il direttore dell’Aiea Rafael Grossi aveva ricevuto già il 13 giugno (giorno dell’inizio dell’attacco israeliano) una lettera dal ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi che lo informava dell’adozione di «speciali misure» per proteggere attrezzature e materiali
radioattivi. È presumibile che il trasferimento immediato dell’uranio rientrasse tra queste.
Il 12 giugno, inoltre, il governo iraniano ha comunicato all’Aiea di aver predisposto un sito nuovo, costruito anche più in profondità rispetto agli 80-90 metri di Fordow: le informazioni su di esso sono scarne, pare si tratti di un impianto di almeno 10 mila metri quadrati, con centrifughe e depositi di stoccaggio, che si troverebbe in una delle montagne della provincia di Isfahan.
«L’uranio viene spostato in continuazione, non è difficile», dice ancora il professor Jeffrey, «nel procedimento industriale per arricchirlo passa di frequente da una struttura all’altra, da un’azienda all’altra». È stoccato in cilindri di metallo sotto forma di polvere che, per dimensione, stanno dentro il bagagliaio di una macchina. Per gli Stati Uniti e Israele, la consegna di quella mezza tonnellata di uranio arricchito è la precondizione per tornare al tavolo del negoziato. E, dunque, la possibile causa di future operazioni militari.
(da La Repubblica)
argomento: Politica | Commenta »
Giugno 27th, 2025 Riccardo Fucile
UN GENIO CHE E’ STATO CAPACE DI INVENTARSI AMAZON MA NON UN MATRIMONIO ORIGINALE
Se aveste i soldi di Jeff Bezos, vi sposereste come lui? Prendereste in ostaggio, pardon in affitto, il Canal Grande di
in affitto, il Canal Grande di
Venezia, cinque alberghi a sette stelle (manco sapevo esistessero), decine di yacht e moto d’acqua, guardie del corpo mimetizzate tra le siepi, siepi in cui far mimetizzare le guardie del corpo, ventisette cambi d’abito per la sposa, schiuma party, pigiama party, party a tema Grande Gatsby (che almeno aveva un dolore dentro) e le Kardashian, gli Elton, le Oprah e le Rania di Giordania come pacchetto glamour inglobato nell’offerta? E poi i contestatori, i sosia, i cacciatori di selfie.
Con questo caldo. E le zanzare. Tantissime, più degli yacht e persino delle Kardashian. Non so voi, ma se fossi io il promesso sposo e avessi 30 milioni di dollari da buttare, li investirei su un’isola deserta e priva di connessioni web per pagarmi l’unico lusso che non ha prezzo: starsene in pace.
Con me vorrei solo mia moglie, senza troppi cambi d’abito (al massimo ventisei). E per i testimoni mi affiderei a ChatGPT.
Si accettano suggerimenti: saranno sicuramente più spiazzanti delle scelte di questi ultraricchi che vivono nel mito dell’esclusività e poi fanno sempre tutti le stesse cose, le più ovvie, ma gonfiandone a dismisura le dimensioni, fino a sprofondare nel grottesco.
Come Beppe Severgnini, anch’io sono rimasto deluso da mister Bezos. Deluso e dispiaciuto per lui. Un genio che è stato capace di inventarsi Amazon, ma non un matrimonio originale.
(da corriere.it)
argomento: Politica | Commenta »
Giugno 27th, 2025 Riccardo Fucile
SILVIA SALIS: “DOPO ANNI DI FAVOLE E’ IL MOMENTO DELLA VERITA’”… CROLLATE LE ENTRATE: FAR VIAGGIARE GRATIS PER AVERE VOTI FA SOLO ACCUMULARE DEBITI MILIONARI
 “La previsioni di ricavi da bigliettazione e abbonamenti era di 70 milioni di euro per il 2024 e di 73,5 milioni per il 2025. Il consuntivo del 2024 ha chiuso a 56,2 milioni, 13,8 milioni sotto il preventivato. A gennaio 2025 era chiaro che la nuova politica tariffaria aveva fallito. I dati dei primi quattro mesi 2025 hanno ancora aggravato la situazione. I ricavi da titoli di viaggio si sono fermati a 16,7 milioni, registrando un calo sensibile rispetto allo stesso periodo del 2023 e del 2024. Se proiettiamo il dato sulla fine dell’anno, per il 2025 si ipotizzano ricavi da titoli di viaggio per 50,7 milioni, con un calo sul preventivato di 22,8 milioni. Nel biennio 2024-2025 la differenza tra i ricavi incassati e quelli stimati dalla previsione aziendale sarebbe di 36,6 milioni di euro“.
“La previsioni di ricavi da bigliettazione e abbonamenti era di 70 milioni di euro per il 2024 e di 73,5 milioni per il 2025. Il consuntivo del 2024 ha chiuso a 56,2 milioni, 13,8 milioni sotto il preventivato. A gennaio 2025 era chiaro che la nuova politica tariffaria aveva fallito. I dati dei primi quattro mesi 2025 hanno ancora aggravato la situazione. I ricavi da titoli di viaggio si sono fermati a 16,7 milioni, registrando un calo sensibile rispetto allo stesso periodo del 2023 e del 2024. Se proiettiamo il dato sulla fine dell’anno, per il 2025 si ipotizzano ricavi da titoli di viaggio per 50,7 milioni, con un calo sul preventivato di 22,8 milioni. Nel biennio 2024-2025 la differenza tra i ricavi incassati e quelli stimati dalla previsione aziendale sarebbe di 36,6 milioni di euro“.
Questi sono i numeri portati oggi in sala rossa dalla sindaca Silvia Salis, numeri che definiscono la situazione di Amt, finita al centro del dibattito pubblico a seguito dell’analisi del collegio sindacale inviata nei giorni scorsi al consiglio di amministrazione di Amt Genova, dove sostanzialmente si dava notizia di “elementi sintomatici di una situazione di crisi d’impresa“, con la richiesta al cda di “predisporre entro 30
giorni un piano di intervento idoneo ad affrontare tempestivamente la situazione in atto”.
“Abbiamo già calendarizzato incontri con l’azienda e i sindacati per individuare le soluzioni percorribili – ha poi aggiunto la sindaca Salis – soluzione che dipenderanno anche dall’entità dello squilibrio economico, per accertare il quale affideremo ad una società di revisione indipendente l’incarico di effettuare una due diligence. Dopo anni di favole sui conti di Amt, questo è il momento dell’impegno del Comune, della trasparenza e della verità. Chi ci ha portato fino a qui non ci faccia la lezione. Ha portato sull’orlo della crisi l’azienda di trasporto dei genovesi, mettendo a rischio utenti e lavoratori”.
La sindaca ha ricordato che il 14 marzo la direzione Partecipate aveva scritto ad Amt, Piciocchi e assessori competenti definendo “irricevibile” la relazione previsionale aziendale 2025-2027 “perché fondata su entrate solo ipotizzabili e fondi pubblici che non trovavano riscontro nella contabilità degli enti”. “Ma la giunta – ha accusato Salis – ha preferito fare finta di nulla, aggravando la situazione di Amt”. Dubbi che erano già stati portati in sala rossa dall’opposizione a novembre, a partire dalla relazione di Deloitte che aveva già acceso il faro sui fondi mancanti.
(da Genova24)
argomento: Politica | Commenta »
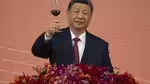 Mentre Israele bombarda le infrastrutture nucleari iraniane e gli Stati Uniti battezzano la loro “Operation Midnight Hammer”, la Cina alza la voce, ma senza alzare le mani. Nei comunicati ufficiali di Pechino, si leggono parole come “violazione della Carta delle Nazioni Unite”, “instabilità globale” e “rispetto per la sovranità”. Ma in filigrana si legge altro. La costruzione di una reputazione alternativa: quella di superpotenza che non ha bisogno di intervenire militarmente per modellare il mondo, l’unica interessata al rispetto del diritto internazionale mentre nessuno sembra più tollerarlo.
Mentre Israele bombarda le infrastrutture nucleari iraniane e gli Stati Uniti battezzano la loro “Operation Midnight Hammer”, la Cina alza la voce, ma senza alzare le mani. Nei comunicati ufficiali di Pechino, si leggono parole come “violazione della Carta delle Nazioni Unite”, “instabilità globale” e “rispetto per la sovranità”. Ma in filigrana si legge altro. La costruzione di una reputazione alternativa: quella di superpotenza che non ha bisogno di intervenire militarmente per modellare il mondo, l’unica interessata al rispetto del diritto internazionale mentre nessuno sembra più tollerarlo. dall’analisi dell’esistente, lo studio delle guerre in corso, e il calcolo delle necessità future. […] Che cosa ci manca? Innanzitutto le truppe. Si pensi solo che ai tempi della Guerra Fredda, la sola Italia doveva garantire una massa di 22 brigate operative dell’esercito, pari a 220 mila soldati armati e schierati, in gran parte nel Nord-Est.
dall’analisi dell’esistente, lo studio delle guerre in corso, e il calcolo delle necessità future. […] Che cosa ci manca? Innanzitutto le truppe. Si pensi solo che ai tempi della Guerra Fredda, la sola Italia doveva garantire una massa di 22 brigate operative dell’esercito, pari a 220 mila soldati armati e schierati, in gran parte nel Nord-Est. Forse davvero fu una specie di globalizzazione. Attorno al X secolo, i cinesi avevano con i paesi stranieri i legami commerciali più fitti di qualunque altro popolo del pianeta.
Forse davvero fu una specie di globalizzazione. Attorno al X secolo, i cinesi avevano con i paesi stranieri i legami commerciali più fitti di qualunque altro popolo del pianeta. della popolazione prosegue senza sosta. Per i gazawi, la guerra non è mai finita: a oltre 600 giorni dal 7 ottobre, i civili palestinesi vivono ancora sotto assedio, tra raid dell’Idf, carenze estreme di cibo, acqua, e altri beni di prima necessità, e una quotidianità segnata dalla paura e dall’incertezza. «Non è facile descrivere la situazione: è molto dura. Non c’è farina, né acqua pulita, tutto è carissimo. Le bombe ci circondano in ogni momento», dice a Open Nadera Mushtha, scrittrice palestinese cresciuta nel quartiere di Shujaiya a Gaza City. «Dal 2 marzo non è entrato più nulla nella Striscia. Qualche settimana fa sono arrivati alcuni aiuti – continua – Ma solo farina». «Stiamo davvero morendo di fame, siamo fisicamente stremati e i nostri corpi sono debilitati», ci spiega Sara Awad, scrittrice e studentessa che vive al nord di Gaza. «Non ricordo l’ultima volta in cui mi sono sentita sazia – prosegue -; mangiamo solo una volta al giorno, e ci vogliono ore per riuscire a procurarci il cibo».
della popolazione prosegue senza sosta. Per i gazawi, la guerra non è mai finita: a oltre 600 giorni dal 7 ottobre, i civili palestinesi vivono ancora sotto assedio, tra raid dell’Idf, carenze estreme di cibo, acqua, e altri beni di prima necessità, e una quotidianità segnata dalla paura e dall’incertezza. «Non è facile descrivere la situazione: è molto dura. Non c’è farina, né acqua pulita, tutto è carissimo. Le bombe ci circondano in ogni momento», dice a Open Nadera Mushtha, scrittrice palestinese cresciuta nel quartiere di Shujaiya a Gaza City. «Dal 2 marzo non è entrato più nulla nella Striscia. Qualche settimana fa sono arrivati alcuni aiuti – continua – Ma solo farina». «Stiamo davvero morendo di fame, siamo fisicamente stremati e i nostri corpi sono debilitati», ci spiega Sara Awad, scrittrice e studentessa che vive al nord di Gaza. «Non ricordo l’ultima volta in cui mi sono sentita sazia – prosegue -; mangiamo solo una volta al giorno, e ci vogliono ore per riuscire a procurarci il cibo». «CONGRATULATIONS WORLD, IT’S TIME FOR PEACE», urla Donald Trump dal social Truth, la sua dependance da single dopo il divorzio con Elon Musk.
«CONGRATULATIONS WORLD, IT’S TIME FOR PEACE», urla Donald Trump dal social Truth, la sua dependance da single dopo il divorzio con Elon Musk. da sentire ma è realtà». Mykhailo Podolyak, primo consigliere del presidente ucraino, parla dopo l’ultimo vertice Nato cui ha preso parte anche Volodymyr Zelensky.
da sentire ma è realtà». Mykhailo Podolyak, primo consigliere del presidente ucraino, parla dopo l’ultimo vertice Nato cui ha preso parte anche Volodymyr Zelensky. Il dubbio si fa certezza. Il tesoro radioattivo degli ayatollah, quei 408,6 chili di uranio arricchito al 60 per cento così prossimi alla soglia utile per costruire la bomba, sono nascosti in qualche laboratorio segreto della Repubblica islamica.
Il dubbio si fa certezza. Il tesoro radioattivo degli ayatollah, quei 408,6 chili di uranio arricchito al 60 per cento così prossimi alla soglia utile per costruire la bomba, sono nascosti in qualche laboratorio segreto della Repubblica islamica. in affitto, il Canal Grande di
in affitto, il Canal Grande di “La previsioni di ricavi da bigliettazione e abbonamenti era di 70 milioni di euro per il 2024 e di 73,5 milioni per il 2025. Il consuntivo del 2024 ha chiuso a 56,2 milioni, 13,8 milioni sotto il preventivato. A gennaio 2025 era chiaro che la nuova politica tariffaria aveva fallito. I dati dei primi quattro mesi 2025 hanno ancora aggravato la situazione. I ricavi da titoli di viaggio si sono fermati a 16,7 milioni, registrando un calo sensibile rispetto allo stesso periodo del 2023 e del 2024. Se proiettiamo il dato sulla fine dell’anno, per il 2025 si ipotizzano ricavi da titoli di viaggio per 50,7 milioni, con un calo sul preventivato di 22,8 milioni. Nel biennio 2024-2025 la differenza tra i ricavi incassati e quelli stimati dalla previsione aziendale sarebbe di 36,6 milioni di euro“.
“La previsioni di ricavi da bigliettazione e abbonamenti era di 70 milioni di euro per il 2024 e di 73,5 milioni per il 2025. Il consuntivo del 2024 ha chiuso a 56,2 milioni, 13,8 milioni sotto il preventivato. A gennaio 2025 era chiaro che la nuova politica tariffaria aveva fallito. I dati dei primi quattro mesi 2025 hanno ancora aggravato la situazione. I ricavi da titoli di viaggio si sono fermati a 16,7 milioni, registrando un calo sensibile rispetto allo stesso periodo del 2023 e del 2024. Se proiettiamo il dato sulla fine dell’anno, per il 2025 si ipotizzano ricavi da titoli di viaggio per 50,7 milioni, con un calo sul preventivato di 22,8 milioni. Nel biennio 2024-2025 la differenza tra i ricavi incassati e quelli stimati dalla previsione aziendale sarebbe di 36,6 milioni di euro“.